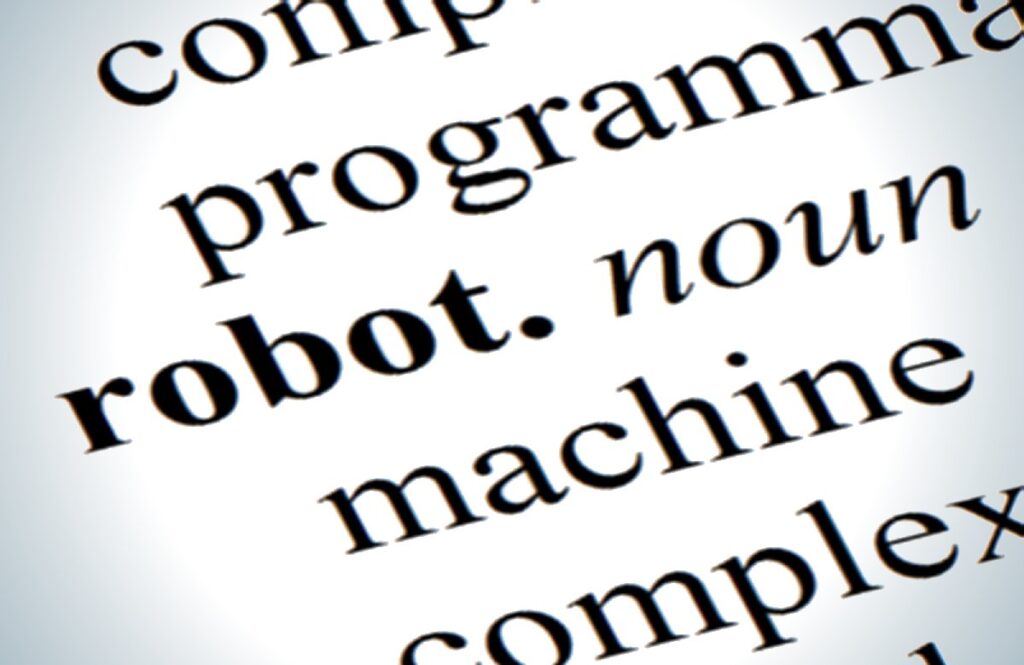Nell’anno appena trascorso mi è capitato di partecipare all’incontro con un giornalista, autore di uno dei tanti libri dedicati al lavoro messo (a suo dire) in pericolo dall’avanzata dei robot, e con un docente universitario, professore emerito di scienza dell’organizzazione, che ha replicato alle affermazioni catastrofiste del giornalista sulla base del buon senso, oltre che della sua competenza professionale. Ne è nata una discussione (meno proficua di quanto avrei sperato, a dire il vero) nella quale ho tentato di obiettare al giornalista che il disastroso quadro prospettato nel suo libro mi pareva frutto di una proiezione su dati correnti realizzata senza tenere conto delle evoluzioni parallele e dei correttivi messi in campo (primo tra tutti, la formazione), un po’ come accadde ai tempi di Ned Ludd – ennesimo caso di pessimismo naif, che piange la rovinosa discesa della pallina lanciata sul piano inclinato come se i suo moto non fosse realmente ostacolato dall’attrito.
In quella sede, avevo suggerito che il fattore chiave per reagire alla (presunta) minaccia, individuando una possibile prospettiva per il lavoro – non solo per la sua persistenza, ma per la sua evoluzione – fosse il valore aggiunto dato dal contributo umano. Un valore evidente, ad esempio, nel lavoro di cura: che in tutte le sue forme può ormai contare sul supporto di dispositivi avanzati, eppure è ben lungi dal poter essere da essi sostituito. Un esempio ancora più evidente di valore aggiunto dell’umano, ho concluso in quella sede, è rappresentato dal mestiere del filosofo, se così si può chiamarlo, che Ludwig Wittgenstein identificava con la “terapia” per curare il ragionamento fallace, e finalizzava alla “scoperta […] dei bernoccoli che l’intelletto si è fatto cozzando contro i limiti del linguaggio”.
Proprio la riflessione di Wittgenstein – proveniente dalla logica matematica, e coevo di Turing – mi sembra l’antidoto migliore per stigmatizzare la tentazione di concludere che, siccome abbiamo insegnato alle macchine a lavorare, e persino a pensare, a parlare, a imparare, lo faranno d’ora in avanti meglio di noi. Perché i limiti del nostro linguaggio, con Wittgenstein, sono i limiti del nostro mondo: gli stessi che noi abbiamo tracciato, e all’interno dei quali le macchine si muovono. Gli stessi che noi possiamo modificare, rivedere, ampliare, grazie alla nostra libertà di parlanti, che non solo definiscono le regole del “gioco linguistico” (ancora Wittgenstein), ma possono romperle per reinventarle.
Non sono sorpresa dal periodico ritorno mediatico di notizie (come questa o questa) riguardanti il successo dei filosofi nel mondo del lavoro, o la graduale presa di coscienza sull’indispensabilità della filosofia nella formazione di base, o il luminoso futuro professionale che attende chi, invece di specializzarsi su tecniche progressivamente sempre più delegabili a sistemi intelligenti sceglie di investire nella terapia del ragionamento, nella comprensione del senso (madre di ogni sensemaking), nell’allenamento dell’intelletto. Siamo insostituibili perché siamo liberi, e la filosofia è la manutenzione di questa libertà. Finché c’è il gioco, non avremo nulla da temere dalla macchina: riuscire sempre a premettere, affiancare, opporre alla macchina, da noi stessa concepita e programmata, l’imprevedibilità, l’apertura, la possibilità del gioco, mi sembra questo il miglior augurio da formulare a tutti noi, filosofi e non, per il nuovo anno.